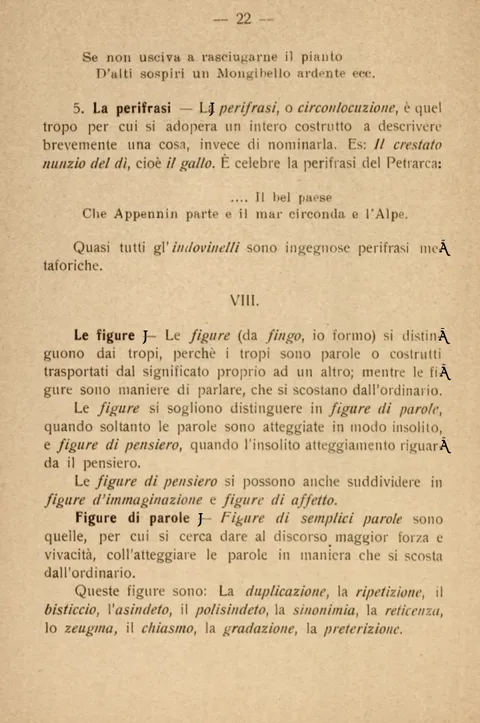BREVISSIMO TRATTATO
DIL E T T E R A T U R A
AD USO DELLE SCUOLE SECONDARIE C O M P IL A T O DA
GIOVANNI LANZALONE
Direttore d e ll Istitu to c o n v itto S e t te m b r in i in S a le r n o
4." edizione con mutazioni ed aggiunte
P a r t e p r i m a
S A L E R N O
T I P . FR A TEL LI J OV ANE
1914
-BREVISSIMO TRATTATO
L E T T E R A T U R
AD USO DELLE SCUOLE SECONDARIE
P a r t e p r i m a
S A L E R N O
T I P . FRATE LLI JOV ANE
PARTE PRIMA
D ell’elo cu zio n e, dell’ inven zione e dello stile.
I.
Definizione La
rettorica
(dalla radice greca ps, dire), o, com e oggi si dice, laletteratura,
è l’arte che insegna la conveniente espressio ne del pensiero.11 pensiero si esprim e con parole; e q u in d i la
parola,
o consid erata isolatamente, o a d o p e rata in frasi, in p r o p o s i zioni, in periodi, in c o m p o n im e n ti di prosa o di verso, form a l’oggetto della letteratura.
La
grammatica
anche studia laparola;
ma la studia in sè, senza metterla in relazione col pensiero; ci dice che ufficio ad e m p ie (nome, verbo, aggettivo ecc.), e com e si o r d in a nel discorso (sintassi); ma non ci dice, se esprim e bene il pensiero. Laletteratura,
invece, paragona la parola al p e n siero, e osserva, se n ’èYespressione conveniente,
cioè se lo e s p rim e con chiarezza, proprietà, eleganza, efficacia, e col co lorito adatto alla prosa o alla poesia, e, in generale, ai varii generi del dire. P e r esem pio in questa frase:Tu conduci un
gilè molto distinto,
la gram m atica non trova alcun errore: ma la letteratura ci avverte che il pensiero non è espresso conproprietà,
perchèconduci
è male usato perporti;
nè conpurità
perchègilè
invece dipanciotto,
edistinto
invece dielegante,
sono francesismi.Elocuzione Quella parte della letteratura, che tratta — —
della scelta delle parole e della loro collocazione nel discorso si dice
elocuzione.
N ell’
elocuzione
q u in d i si tratta delledoti della lingua,
dei
traslati
e dellefigure.
P u r i t à Il p rim o pregio della
elocuzione,
la prim a dote della lin g u a adoperata , è lapurità.
La
purità
è u n a dote d ell’elocuzione, che consiste nello ad o p e ra re quelle parole e quei costrutti, che sono conformi all’in dole della lingua, in cui si parla o scrive. C o m e l’oro p u r o è quello non fram m isto con altri metalli, cosìlingua
pura
è quella no n co n tam in ata da parole e costrutti stranieri.Idiotismi U n a delle parti essenziali della p u rità co n siste nel fare b u o n uso
degl'idiotismi
(da toioc, proprio).G l ’
idiotismi
sono m odi particolari di una lingua, con trarii alla g ram m atic a generale, ma usati dai ben parlanti e dai b u o n i scrittori. S ono stati an c h e definiti: sgram m aticature eleganti. Esempi:N oi si va,
invece di:N o i andiamo
L ’anno che voi veniste,
invece di:L ’anno in cui veniste.
Locuzioni I m portantissim e s o n o anche le
locuzioni,
(da
loquor,
parlo) cioè m aniere di dire, il cui significato s ’im pa ra dall’uso, e no n si può' c o m p re n d e r e dalle singole parole.Le
locuzioni
ce le dà il popolo, e bisogna accettarle come sono, senza p u n to alterarle.D i punto in bianco
è una locu zione, che significa:Tutto ad un tratto.
Noi non potrem m o dire invece:D i bianco in punto.
Dipalo in frasca,
non po treb b e cambiarsi in:D i frasca in palo.
Frasi e proverbii N o n si d e b b o n o c o n fo n d e re le
lo
cuzioni
con lefra si.
Basta u n ire alcune parole, che abbiano un significato, per form a re un afrase.
Lefr a s i
le facciamo noi tutti, parlando; lelocuzioni
le fa il popolo, com e fa i p ro verbii. I proverbii sono m assim e popolari, che hanno una— — — —
f orm a fissa; per es.:
Presto e bene raro avviene
D al dire
al fa re ci corre il mare
O g n i popolo, ogni lingua ha i p r o verbi i suoi. O g n i proverbio contiene una massima; non ogni massim a però è un proverbio .P u rità dei costrutti La purezza della elocuzione non consiste solo nei singoli vocaboli, ma anche nel m o d o di o r dinarli in frasi, in proposizioni, in periodi.
La p u rità della lingua si osserva q u indi anche nel m odo di form are il perio do. 11 periodo latino è ampio, maestoso, intricato. 11 periodo italiano dev'essere più semplice e più piano, com e richiede l’indole della lingua nostra.
Vizii contrarii alla purezza La
purezza
di una lin gua può essere guasta da diversi vizii. I principali sono: 1 solecismi, i barbarismi, i provincialismi, gli arcaismi, i n e o logismi.Solecismi Si chiam ano
solecismi
alcune sg ram m atica ture ineleganti, in cui ca d o n o quelli, che parlano e scriv ono scorrettamente. F u r o n o così detti dalla città diSoli,
nella Cilicia, i cui abitanti parlavano male il greco. Esem pi disolecismi
italiani:Più peggio
invece dipegg io-- Onde venire
, in ca m bio di:Per venire
Il di lei marito
, perII marito
di lei.
Barbarism i Si ch iam a n o
barbarismi
i vocaboli e i costrutti, tratti da lingue straniere.Nella lingua italiana i barba rism i più frequenti sono i
gallicismi
ofrancesism i;
e ciò avviene, sia per la vicinanza della F rancia all’ Italia, sia per la parentela delle d u e lin gue, sia per le strette e frequenti relazioni artistiche, scien. tifiche, commerciali, politiche, fra i due popoli. Esempi:Gilè
per
panciotto: decidere
perrisolvere, lo vado a dirvi
è un f u tu ro perifrastico alla francese(je vais vous dire)
in cam bio di:lo vi dirò.
Così anche:È questo che io feci,
invece di:— — — — — — — —
Questo io feci
Con degli amici
, per:Con alcuni amici.
Si p u ò q u in d i avere u n a frase, un intero periodo, di struttura francese, no n ostante che tutte le parole usatevi siano prette italiane.Provincialismi S o n o parole e m odi di dire proprii di qualche provincia. Si d ic o n o anche
regionalismi
le parole e m o d i di dire p roprii di qualche regione. Così:Io lasciai me
ravigliato,
invece di:Io rimasi meravigliato
, è unregiona
lismo
pugliese.I
provincialismi
e iregionalismi
p o sso n o essere intro dotti nella lingua c o m u n e solo da scrittori di g ran d e autorità.Arcaismi Si chiam a no
arcaismi
(da àpyaTo;, antico) le voci antiche cadute in disuso. Esse s o n o di due specie: 1.° P arole che no n si usano più(diente per quale, sirocchia
pe r
sorella
), o h a n n o cam biato d esinenz a(ormora
perorme,
ramora
perrami)]
2.° Parole, che si usano tuttora, ma con significato diverso. Esempi:Carogna
significavacadavere li
mano:
ed ora significacorpo morto di animale: brigante,
che ora vuol diremalfattore di campagna,
un te m p o significavauomo che briga,
(quel che oggi si diceaffarista),
ovverouomo
amante delle allegre brigate
Si d e b b o n o rig u ard are come arcaism i anc he i costrutti oggi disusati; come:Non potè fa re
che non piangesse,
invece di:Non potè f a r di meno di
piangere.
Neologismi I
neologismi
(da vs'o?, n u o v o e Àoyoc, p a rola) so n o parole e locuzio ni di n u o v a form azione. Si possonousare, q u a n d o e s p r im o n o idee o cose nuove, p e r le quali la lingua no n ha altre parole adatte. Esempi:
telegrafo, tele
fono, termometro, automobile
,piroscafo.
S o n o invece da f u ggirsi i neologism i inutili. Esempi:
Traslocare
pertrasferire
;uniforme
p e rdivisa; giocattolo
p e rbalocco.
— — — — —
II.
P ro p r ie t à La
proprietà
è quella dote dell’elocuzione, che consiste nell’a d o p e ra re vocaboli e m odi di dire, che e s p rim a n oesattamente
il nostro concetto.Q u in d i la p rim a c o ndizione p e r parlare con proprietà, è di avere idee chiare e precise; la se conda è di avere gran perizia della lingua, e conoscere
esattamente
il valore di cia scun vocabolo. E qui è o p p o r tu n o ricordare ai giovani il savio consiglio delDe Amicis:
S tu d iare il vocabolario.Sinonimi P e r non peccare co n tro la proprietà, bisogna stu d iar bene il significato dei
sinonimi
(da auvóvuao;, di egual nome), i quali so no parole, che h an n o co m u n e fra loro il significato generale, ma si d is tin g u o n o p e r qualche idea accessoria. Esempi:Cavallo, destriero, corsiero, palafreno,
rozza, ronzino,
so n o parole che tutte significano u n o stesso animale. P erò,cavallo
esprim e l’ idea in generale;destriero
è il cavallo da guerra;
corsiero
è il cavallo da corsa;pala
freno
è il cavallo da parata, o da signora;rozza
è un ca vallo da strapazzo e malandato;ronzino
è un cavallo o r d i nario m a vivace.Allungare
eprolungare
E n tram b i questi verbi espri m o n o l’idea dirender lungo;
m a il secondo significarender
lungo aggiungendo.
Noi, quindi,allunghiamo il braccio,
non10 prolunghiamo;
maprolunghiamo una linea sulla lavagna.
Unico
esolo
La madre non lasciava mai solo il suo
figliuolo unico.
Esolo
chi non ha co m pagnia; èunico
chinon ha altri della sua specie.
Dispiacere, dolore
Il p rim o è un leggero dolore morale, 11 se condo p u ò essere anche fisico, e q u a n d o rig u a rd a il morale— — — — —
dice assai più di
dispiacere.
Es:N ’ebbi dispiacere, anzi un
vero dolore.
Ma non potrei dire:Io ho un dispiacere al braccio.
O ttim o dizionario dei sin onim i è quello del
Tommaseo.
Vi so n o poi altri sinonim i, e so n o pochissimi, i quali non h an n o vera differenza di significato , ma si preferisce l'u n o o l'altro di essi, se condo che si scrive in prosa o in verso, o se co n d o che m eglio richieda l'arm o n ia della frase o del perio do. Esempi:
Badia, abbadia; consenso, consenti
mento; orologio
eorinolo.
Omonimi Gli o m onim i (da 6 u .'jvuuo?, dello stesso n o me) so n o parole di form a identica, ma di significato diver so. Esempio:
tórre
da togliere,tórre
edifizio;vólto
da vol gere,vólto
viso;mèsse
da mietere,mésse
da mettere. Q u e ste parole si d istin g u o n o dalla p r o n u n z ia stretta o larga della vocale su cui cade l’accento, e dal significato richie sto dal contesto del discorso.Im proprietà Si pecca anche c o n tro la proprietà: 1.° coll’a d o p e ra re parole tr o p p o generiche invece di pa role particolari. Esempio:
Vi era un monte, vi era una valle,
vi era una pianura, vi era un fium e.
Si parlerebbe più pro priam ente, dicendo:Sorgeva un monte, verdeggiava o si a-
priva una valle, si stendeva una pianura
,scorreva un fiume;
’2." coll’ es p rim ere (senza necessità o speciale o p p o r tu nità) con nomi astratti persone e cose sensibili. Esempio:
Quell’uomo è una notabilità,
invece di dire :Quello è un
uomo notabile;
3.° coll’accozzare parole, che e s p rim o n o idee contradit- torie. Esempio:
Sotterrati nel sangue.
Nel sa ngue si può r im a n e r sepolti, ma n o n sotterrati (perchè questa parola si gnifica p r o p ria m e n tesepolti sotto terra).
E, in generale, si avverta, che la p r o p r i e t à , cioè 1’ e satta espressio ne del nostro pensiero, non risulta solo dalle
-— —
-semplici parole, ma anche dall’ uso esatto d eg l’ interi co strutti.
III.
Armonia Le parole, essendo suoni, h an n o n a tu ra l m ente un
'armonia
conform e all’indole della lingua, a cui a p p arte ngono.L'armonia
è quella dote d ell’ e lo c u z io n e , che consiste nello scegliere e o r d in a re le parole in m odo , che d ia n o un su o n o gradevole all’orecchio, e a p p ro p ria to al p e n siero espresso.L’arm o n ia si dice
semplice
, se m ira solo a dilettare l’o recchio. Si diceimitativa,
se il s u o n o delle parole esprim e al vivo le cose.Vizii contro l'arm onia semplice:
1. L
'iato
si ha, q u an d o , per l’incontro di più vocali, si p r o d u c e una sg radevole a p e rtu ra di bocca (in latinohiare,
sbadigliare). Esempio:
M ai io udirò.
2. La
cacofonia
(x«xo; cattivo, v»v7( su ono) risulta dalla rip etizio ne vicina delle stesse lettere o sillabe. Esempio:Tra
tanti traditori.
3. Le
rime
e iversi
in prosa sono anche, in generale, da fuggirsi. Il Boccaccio e rrò q u a n d o scrisse :Poiché ella
si tacque, come alla reina piacque, Filomena così cominciò.
4. La
monotonia
(da uovo?, solo, rovo;, suono) è u n if o r mità di su o n o nella disposizio ne delle parole. Alcuni • (per esempio) m e ttono la proposizione principale se m p re a p r in cipio del periodo, o se m pre nel mezzo, o se m pre in fine. Sarà meglio variarne la collocazione. Sarà anche b en e il variare i periodi lu nghi coi corti e coi giusti. In generale, si deve e vitare di p o rre molte parole sdruccio le di seguito, o molte t ro n ch e , o molte bisillabe, com e anche di finire il periodo
-con u n a parola tronca; salvo che tutto ciò non si faccia per arm o n ia imitativa. A nche la varia lunghezza e la varia for m a delle proposizioni e le o p p o r tu n e pause della p u n te g gia tura conferiscono aH’arm onia.
Esempio di arm o n ia im itativa p u ò esserci la famosa ot tava del Tasso, il quale colla scelta di rim e rim bom ba nti, di vocali cupe, di c onsonanti aspre e s o n o r e , ci fa quasi sentire lo strepito della tro m b a infernale:
Chiama gli a b ita to r’ de l ’ombre eterne Il rauco suon della tartarea tromba, Trem an le spaziose atre caverne, E l ’aer cieco a quel r u m o r rim bomba; Nè stridendo così dalle superne Regioni del cielo il f'olgcr p io m b a; Nè si scossa giam m ai trem a la terra Q uando i vapori in sen gravida serra.
Ed ecco com e Dante, con la scelta della rima fischiante in
ia,
e delle consonanti , più o m e no sibilanti,s z g c v,
unite a preferenza alle vocali / ed
e,
ci fa sentire il fischio di un tizzo verde al fuoco:Come d ’un stizzo verde c ’arso sia Da l ’un dei capì, e che dall'altro geme E cigola pel vento che va via.
La lingua italiana, con la strao rd in a ria varietà di suoni che ha, si presta benissim o a es p rim ere col s u o n o q u a lu n q u e cosa.
L ’armonia imitativa
è so p ra tu tto necessaria alla poe sia; ma anche nella prosa deve farsene uso conveniente. Così il Manzoni, con la semplice scelta di parole bisillabe, ci fa
sentire il g ran d in a re dei sassi sul p ortone del G overnatore :
Con spessi e fitti colpi di sassi alla porta
L’arm o n ia imita tiva (detta altrimentionomatopeica)
colorisce, per così dire, il significato d ’un costrutto, a g g iu n g e n d o alVidea
della cosa, ilsuono
, quasi, di quella. Chi descrivesse una battaglia con parole e frasi di s u o n o tenue e gentile, o un m attin o di pri mavera con parole aspre e chiocce, non d a re b b e laforma
conveniente
al suo pensiero.IV. Altre doti d
t\Velocuzione
sono:La chiarezza È quella dote d ell’elocuzione, che consi ste nelTesprim ere il nostro pensiero in modo, che sia tutto e subito c om preso. Q u esta dote è specialm ente un a consegue nza della
purezza
e dellaproprietà.
C o n tra rie alla chiarezza sono leambiguità
oanfibologie
(da dubbio so), cioè pa role o frasi, che per sè stesse, o per la loro collocazione, han n o significato d u b b io . Es: /libri d'oro della vecchiezza di
Cicerone;
si d ireb b e assai più chiaramente:Gli aurei libri
di Cicerone intorno alla vecchiezza.
Il difetto contra rio alla
chiarezza
dicesioscurità.
N o n è però veraoscurità
quella che d ip e n d e dall'ig n o ra n za di chi legge, o da su b lim ità e densità di pensieri. Q u esta sublim e oscurità piu ttosto p u ò paragonarsi aH’abba glia m e nto pro d o tto da tr o p p a luce, o all’ac q u a dell’oceano, la quale, benché limpidissima, con la sua massa en o rm e cela il fondo.I term ini d ’una proposizione si possono d isp o r re in
or
dine diretto
(soggetto, predicato, coi rispettivi complementi), o inordine invèrso.
La lingua latina, la greca, e, in g e n e rale, tutte le lingue che han n o i casi, possono fare m olto uso—
—
d e ll’inversione, senza n u o c e re alla chiarezza. Nella lingua nostra, priva di casi, la
sintassi inversa
si deve ad operare con cautela; e si usa nella poesia più che nella prosa.La brevità È quella dote dell’elocuzione, che consiste n ell'esprim ere i proprii concetti nel m in o r n u m e r o di parole possibile. 11 vizio co n tra rio a questo pregio dicesi
prolissità.
P e r eccessivo am ore di
brevità
si cade facilmenteneW’oscu-
rità
: com e vi ca ddero talora, fra gli scrittori latini, Tacito, e, fra i nostri, il Davanzati.L’e l e g a n z a Deriva dal latino
eligere,
scegliere. È quella dote dell’elocuzione, che rende il discorso forbito, ornato, g e n tile. Risulta quasi dal com plesso delle altre doti. Q uindi una elocuzione che non sia pura, che no n sia propria, armoniosa e chiara, non potrà dirsi veram ente elegante. L’am ore delY elocuzione elegante
ci fa evitare le frasi e le parole plebee, q u a n d o no n siano necessarie al soggetto, come:pancia, trippa,
crepare, grattare dov’è la rogna
ecc.; ci fa fuggire le inutili ripetizioni, e usa re invece o p p o r tu n a m e n te i pronom i, i sino nimi, e la figura dell'ellissi;
e, in generale, ci fa porre molto stu d io nella collocazione delle parole e n ell’uso delle figure e dei tropi, di cui p arle re m o fra breve.C o n tra ria all
'eleganza
è lasciattezza
e latrivialità.
Ele gante riuscì il Machiavelli, q u a n d o scrisse nelleStorie Fio
rentine: Fecesi di quell’acquisto in Firenze allegrezza solenne.
S arebbe riuscito sciatto, se avesse scritto invece:
Fecesi al
legrezza solenne in Firenze di quell’acquisto.
Ma l’eccessivo studio dell’eleganza c o n d u c e allaricercatezza,
o, com e oggi si dice,preziosità;
all’affettazione,
allaleziosità.
Spesso fu ricer cato, e qualche volta affettato, il Boccaccio. Così, fuaffettato
q u a n d o scrisse:
Fu re di Cicilia coronato Manfredi,
e per eccessivo studio di eleganza e di a r m o n ia latineggiante, egli violò l’indole della nostra lingua, che am a costrutti più sem— — -
plici e piani. La
vera eleganza
è se m pre accom pagnata dallanaturalezza,
com e si a m m ir a n ell’Ariosto, nel Leopardi e nel Manzoni.L’evidenza È la
chiarezza
portata a tal punto, che le cose non solo si capiscono, ma ci se m b ra vederle. Esempi:Il conte Ugolino,
diDante: la peste di Milano,
neiPromessi
Sposi.
Effetto dell1evidenza
èYefficacia,
cioè il fare viva im pressione sull'a nim o del lettore.V.
Tropi I
Tropi
ele figure
se rvono per dare colorito ed efficacia all’elocuzione. Esse m alam ente si diconoeleganti
improprietà;
anzi sono il linguaggio p ro p rio della passione e deH’im m agin azione, com e bene osserva il Fornari.7
ropo
(dal greco rps-w. io volgo) è lo stesso chetras
lato
(dal latinotransfero
, io trasporto) e significa parola trasportata da un significato, che l’è proprio, ad un altro.Vi sono
tropi,
otraslati,
di semplici parole, e tropi d ’in teri costrutti. Ai primi ap p a rten g o n o : Lametafora,
lame
tonimia,
lasineddoche, \'antonomasia, Xeufemismo.
Ai secondi ap p a rten g o n o :
L’allegoria,
l'ironia,
ilsarca
smo,
l’iperbole,
laperifrasi.
M e tafora La
metafora
(da a rxa/c'pw. trasporto) è quel tropo, per cui si trasferisce un a parola dal p r o p rio signifi cato ad un altro, che ha col p rim o relazione di somiglianza.Esempio:
Ulisse era una volpe.
Qui la parolavolpe
è stata trasportata dal suo significato proprio , di animale noto per la sua astuzia, a significare un uomo, che per la sua astuzia pu ò paragonarsi ad una volpe. P e r forza d 'im m a g i nazio ne si passa, d u n q u e , dall’idea di sim iglianza all’idea— — — -
d ’identità. Infatti,
era una volpe,
equivale a dire:Era astuto
come una volpe.
A ragione q u in d i la metafora fu anche definita: una
similitudine abbreviata.
Essa fu detta laregina dei tropi,
per l’uso svariato che se ne fa, e per la forza e la grazia che conferisce al dire, q u a n d o è o p p o r tu n a m e n te adoperata.
La metafora è biasimevole, q u a n d o è presa da cose poco note, o tr o p p o triviali, o sp r o p o rz io n a te all’idea, o da simi glianze tr o p p o lontane o inesistenti. Ecco com e u n o scrittore del 600 ci descrive gli spari del c a n n o n e con metafore scon venienti:
Così con bocca or di pietà digiuna T u o n a per f u l m i n a r le m u ra immote, Da gran gola lanciando in fier rim bombo
S p a ti di foco e vom iti di piombo.
La
metafora
p re n d e il n o m e dicatacresi
(da xxxxypxw, io abuso) q u a n d o è c o m u n e m e n te usata, perchè m anca nella lingua altra parola p ro p ria . Esempi: legambe
del ta volino; ilcollo
della bottiglia.Metonimia La
metonimia
(da iaó'cojvujjux) significa ca m biam ento di nome: e per essa anche si trasferisce un voca bolo da u n o ad u n altro significato, n o n però per ragioni di somiglianza, ma per altre relazioni.Le principali di queste relazioni, e i principali scam bi di n o m e per esse fatti, sono:
1.
La causa per l'effetto.
Esempi:Per gli occhi fui di grave dolor m unto.
In questo verso Dante usa
dolore
perlagrime,
cioè la causa p e r l’effetto. - — P etr arca :
E di bianca p a u r a il viso tinse.
La paura non è bianca, tua è causa della pallidezza. Così anche si dice l’autore per l'opera sua. Es:
H ai letto
D ante?
L’ opera è un effetto dell'auto re.2.
L ’effetto per la causa.
P er esempio:Rispetta la mia
canizie
.Canizie
, per vecchiezza, di cui è l’effetto.Pane g u a
dagnato col proprio sudore. Sudore,
invece della fatica, che lo produce.Squilla,
per campana, di cui è effetto la squilla. 3.Il protettore per la cosa protetta.
Es:Bacco,
per vino,Marte,
per la guerra,Venere
per l’ am ore,Cerere,
per il g r a n o o il pane.4.
Il possessore per la cosa posseduta.
Virgilio scrisse:Già arde il prossimo Ucalegone,
cioè la casa di Ucalegone. 5.Lo strumento per l ’opera a cui serve.
Esempi:Pen
nello,
per pittura;penna,
per lo scrivere;mano,
per l ’opera; com e scrisse il Tasso:Molto egli oprò col senno e con la
mano.
6.
La materia per la cosa che n ’è fatta.
Es:Ferro,
in vece di spada;legno,
per nave o carrozza;sacri bronzi,
per cam pana.Il Monti scrisse:
Quando Giason dal Pelio Spinse nel m a r g li abeti,
cioè le
navi
costrutte diabete.
7.
Il segno per la cosa significata. Il lauro
, per la gloria poetica o militare;la toga,
per la professione forense.8.
L ’astratto per il concreto.
Esempi:Io ho molte cono
scenze,
per conoscenti;l ’ambizione non rispetta parentele,
cioè gli am biziosi non rispettano i parenti. 9.
Il concreto per l ’astratto.
Dante:Ipocrisia, lusinghe e chi a ffa ttu ra .
Chi affattura,
concreto, sta per l ’astratto fattucchieria, malìa.VI.
Sineddoche La
sineddoche
(da <rjvo£yoy.at. com prendo)è quel tropo, per cui si trasferisce u n a parola da un signifi cato ad un altro, che ha col p r im o relazione di c o m p re n sione. Q u esto tro p o non è che u n a specie della
metonimia
, con cui molti retori lo fondono,Q u in d i per esso si sc a m b ia n o :
1.
Il tutto per la parte.
Es:S'armò d ’Asia e di Libia
il popol misto. Asia,
dice il Tasso, per u n a parte dell’Asia. E il Filicaia :E quei che calca la Bistonia neve E quel che il N ilo e che V Or onte beve ;
cioè quelli che si dissetano delle ac q u e del
Nilo
edeU'Oronte,
non che le bevono
tutte.
2.
La parte per il tutto.
Es:prora,
invece di nave;tetto,
per casa ;
polo
per cielo.3.
Il genere per la specie.
Es:mortali,
invece diuomini.
O animai grazioso e benigno
( Dante ) ; qui,animale,
per uom o.4.
La specie per il genere.
Es:Aquilone, austro,
per q u a l u n q u e vento.—
5.
Il singolare per il plurale.
Es:il Romano,
peri Ro
mani ; guardare con placido occhio ; mordere con maligno
dente ;
invece diplacidi occhi
emaligni denti.
6.
Il plurale per il singolare.
Es:A l tempo dei Ciceroni
e dei Cesari,
in luogo di dire : Al te m po di Cicerone e di Cesare. Si badi a non c o n fo n d e re questa speciale sineddoche con l’antonomasia.Antonomasia L
'antonomasia
(da ’avxt. invece, e cvoux, nome), è quel tropo che consiste nel trasportare u n a parola dal significato di n om e p r o p rio a quello di n o m e com une. (Mecenate,
per protetto re di letterati; iTantali,
iNeroni,
per uom ini sacrileghi com e Tantalo , feroci com e Nerone) o nel trasportare un n om e c o m u n e a significato di nom e p ro p rio(il Poeta,
per Dante,il Venosino,
per Orazio,il Segretario
Fiorentino,
per Machiavelli).Eufemismo Consiste nell’usare un a parola o frase g e n tile per esprim ere u n a cosa sconcia o orribile Es:
Mani
chini,
per manette. Ele gante m ente ilDe Amicis : Gli diede
un calcio.... nell’ordinario bersaglio dei calci.
U n a m a dre non dice:Il mio figliuolo è morto;
ma:Il mio figliuolo è votato
in cielo:
ovveroÈ andato in paradiso.
E usa u n ’espressione assaipropria
al suo particolare sentimento . (Eufemismo, da .ù e cpvja ', io dico bene).VII.
Traslati d ’ interi costrutti s o n o :
1. L’allegoria L
'allegoria
(da altro, e àyopiut.^ parlo) è quel tropo, per il quale un intero costrutto è usato a significare u n a cosa simile a quella espressa dal suo senso letterale. Essa q u indi si p u ò dire un metafora continuata.—
—
—
Si p u ò estende re per più periodi, e perfino per u n ’ intera com posiz ione. La
Divina Commedia
è tutta u n ’allegoria.
L'allegoria
si dicepura,
q u a n d o tutte le parole che la c o m p o n g o n o , sono in senso metaforico. E s e m p io : ecco in che m o d o D ante allegorizza l’avarizia :Maledetta sie tu, antica lupa.
Che più di tutte l'a ltre bestie hai preda, Per la tua fame senza fine cupa.
Si dice
mista,
q u a n d o alle parole metaforiche sono co n g iu n te parole di significato proprio. Esempio: Dante :Per correr m iglior acqua alza le vele Ornai la navicella del mio ingegno, Che lascia dieiro a se m a r sì crudele.
In questa terzin a le parole
acqua, vele, navicella, mare,
s o n o metaforiche: ma la parola
ingegno
è in senso proprio, ed è com e u n o spiraglio per cui si vede il vero pensiero, ve lato da quelle parole; cioè:Per trattare un argomento mi
gliore, il mio ingegno solleva lo stile, lasciando il doloroso
tema delle pene infernali.
2. L’ ironia L ’
ironia
(da sìfwvsta, dissimulazione nel parlare) è quel tropo, per il quale un in tero costrutto è tra sportato a significare il co n tra rio del suo senso letterale. Q u in d i i Latini la c h ia m a ro n oinversione
, cioèstravolgimento
del senso delle parole.
Esempio: Dante, p a rla n d o a Firenze:
Or ti fa lieta, che tu n ’hai ben d ’onde. Tu ricca, tu con pace, tu con senno.
Q ui Dante in tende dire il co n tra rio di quel che le pa
role sig nificano; cioè:
Piangi, o Firenze, chè n ’hai ben ra
gione, tu che sei povera, discorde e dissennata!
3. Il sarcasm o Si dice
sarcasmo
(da <jxpxàCc>. io m o r d o le labbra) u n ’ironia molto a m ara e p u ngente. Es: Nel Tasso, così Argante insulta Tancredi, rin facciar dogli l’uc cisione della g u e rrie ra C lorin da:Chè non potrai da le mie m ani, o forte De le donne uccisor, fu ggir la morte.
E Tancredi, ritorce ndo il sarcasmo, risponde:
Vienne in disparte pu r tu, che omicida sei dei giganti solo e degli eroi: l'uccisor de le femmine ti stida.
4. L’ iperbole L’ ip erbole (da ó^ pjióXr, esagerazione) è un tropo, che ingrandisce o impiccolisce le cose oltre il vero, per accrescerne l’im pressione. Esempio:
fa r piangere
i sassi.
11 Monti:
Il pie’ sì lento
Che le lumache al paragon son veltri.
È bella e p ro p ria l’iperbole, q u a n d o esprim e u n a reale im pre ssione eccessiva della fantasia e dell’anim o. E falsa e brutta , q u a n d o non è che u n o sforzato e ridicolo giu oco della mente. Ecco, p. e., l’iperbole d ’un seicentista, per la m o rte del Bembo:
Per la morte del Bembo, un sì gran pianto Piovve dagli occhi de l'u m a n a gente. Ch'era per atfogar veracemente T utto il genere u m a n o in ogni canto,
—
-Se non usciva a rasciugarne il pianto D ’alti sospiri un Mongibello ardente ecc.
5. La perifrasi La
perìfrasi,
ocirconlocuzione,
è quel tro p o per cui si a d o p e ra un intero c o strutto a descrivere b rev e m en te u n a cosa, invece di nom inarla. Es:Il crestato
nunzio del dì,
cioèil gallo.
E celebre la perifrasi del Petrarca:.... Il bel paese
Che Appennin parte e i] m a r circonda e l'Alpe.
Q uasi tutti g l’
indovinelli
so n o in g e gnose perifrasi me taforiche.V i l i .
Le figure Le
figure
(dafingo,
io form o) si distin g u o n o dai tropi, perchè i tropi s o n o parole o costrutti trasportati dal significato p ro p rio ad un altro; mentre le fi g u r e so n o m aniere di parlare, che si scostano dall’ordinario. Lefig u re
si sogliono d istin g u ere infig u re di parole,
q u a n d o soltanto le parole sono atteggiate in m o d o insolito, e
figure di pensiero,
q u a n d o l'insolito atteggiam ento riguar da il pensiero.Le
fig ure di pensiero
si p o ssono anche suddividere infigure d ’immaginazione
efig u re di affetto.
F ig ure di parole
Figure di semplici parole
so no quelle, p e r cui si cerca dare al disc orso m a g g io r forza e vivacità, coll'atteggiare le parole in m aniera che si scosta d all’ordinario.Q u este figure sono: La
duplicazione,
laripetizione,
ilbisticcio,
l’asindeto,
ilpolisindeto,
lasinonimia,
lareticenza,
lo
zeugma,
ilchiasmo,
lagradazione,
lapreterizione.
— — —
Duplicazione Dicesi anche
raddoppiamento
oepizeasi
(da ’c - i £ s c o n j u n c t i o ) , e consiste nel ripetere di seguito u n a o più parole. Dante:
Non son colui, non son coi ni che credi. Tasso:
A rm e arnie freme il forsennato, e insiema
La gioventù superba a rm e a rm e freme.
Ripetizione Q uesta fig ura (che può dirsi anche
ana
fora,
da àvxcpopà. il c o n d u r r e indietro) consiste nel replicare la stessa parola o costrutto a principio di più proposizioni, o m e m bri, o periodi. Dante:P e r m e si va nella città dolente. P e r me si va nell 'eterno dolore. P e r me si va fra la perduta gente.
U n a m a n iera speciale di ripetizione è il
polìptoto
(daoXj t m t o v, che ha molte term inazioni), il quale si ha, q u a n d o
si ripete una parola v aria n d o n e il caso, o il n u m e ro , o il genere, o la persona. I latini chiam a no questa figura
traductio.
Ecco un esem pio del Marini:
Oppongonsi elementi ad elementi
Nubi a nubi, acque ad acque, e venti a venti.
Se poi la parola è ripetuta in senso diverso, allora la
ripetizione
piglia il nom e diAntanac/asi
(àvTxvàxXai;, il rim balzare) oDilogia
(Suo. du e e Xoyo?. parola, significato). Es: Sei statonel fondo?
N el fondo,
p u r troppo, d ’ogni male !—
—
-Bisticcio Affine alle precedenti figure è il
Bisticcio,
o
Paronomasia
(da Ttapovoaaaia. in latinoannominatio).
C o n siste nel ripetere voci quasi simili nel suono, ma moltodiverse nel significato. Dante :
Li nostri voti e vóti in alcun canto. Io fui per rito r n a r più volte volto. Nel modo che il seguente canto canta.
Asindeto Q u e sta figura ( da privativo e cjvSctos. legato in sie m e ) consiste nel so p p r im e r e le congiunzioni, pe r dare rapid ità al discorso. Il M anzoni :
Un corriere è salito in arcioni ; Prende un foglio, il ripone, s'a vvia ; Sferza, sprona, divora la v i a ; Ogni villa si desta al ru m o r.
Polisindeto (Da gX j;, m olto e tóvòìto?, legato insieme). C onsiste nel ripetere più del necessario la congiunzio ne
e.
Si usa q u a n d o si vuol dare 1’ im pre ssione di u n a grande e n u m eraz io n e.
Il Manzoni :
E ripensò le mobili Tende e i percossi valli, E il lampo dei m anipoli, E l ’onda dei cavalli, E il concitato imperio, E il celere obbedir.
S inonim ia f Da Tuvf.Wjj.o?, di ugual n o m e ). Consiste n e i re s p r iin e r e la stessa cosa con più parole, che abbiano significato analogo, il quale però ad ogni parola si rinforzi.
—
—
— -
Es:
Senza l ’aiuto dell’eloquenza non è arte alcuna che possa
compiutamente il suo ufficio eseguire, anzi son tutte mutole,
senza lingua, senza voce e senza spirito.
Reticenza E u n a figura ( da
reticeo,
io taccio ) per la quale si tronca volo ntariam ente a un tratto il dire, per va rie ragioni di o p p o r tu n ità e di efficacia. NellaGerusalemme
Liberata
il MagoIsmeno
invoca gli spiriti infernali per in canta r la selva, e, v e d e n d o che ta rd a n o a venire, li minaccia :Che sì... che sì... volea più d i r ; ma intanto Conobbe c h ’eseguito era l ’ incanto.
Zeugma Consiste nel dare un costrutto solo a due o più parole o frasi che lo v o rre b b e r o diverso (da
10 aggiogo). Dante :
P arlare e la g rim a r vedrai insieme.
11
vedrai
si conviene allagrimare,
m a non alparlare,
11 quale si
sente,
non sivede.
Così, è c om unissim o il dire :10 vado e vengo da Napoli ;
invece sarebbe tro p p o lu ngo e inelegante :lo vado a Napoli e vengo da Napoli.
Chiasmo E un a figura che piglia il nom e della let tera greca / (chi), perchè le parole si d is p o n g o n o in s im m e tria da co rrisp o n d e rsi a p p u n t o com e le quattro p u n te del / . 11 P arin i :
... O se d ’argento
E d ’oro incider vuol gioielli e vasi P er orn am en to a nuove spose e a mense.
Mense
co rr isp o n d e avasi
edargento ; nuove spose
agioielli
eoro.
Se le parole non fossero disposte in m o d o fi ——
—
gurato, si direbbe:
O se vuole incidere gioielli d'oro per or
namento a nuove spose, o vasi d ’argento per ornamento a
mense.
G ra daz ione F u detta dai Greci /.Xiua; (scala), e po trebbe anche chiamarsi
progressione.
E il salire gradatamente da una circostanza ad u n ’altra m aggiore, finché la cosa sia portata al suo colmo. Questa, non senza ragione, è da molti r ig u ard ata com e figura di pensiero. 11 Tasso:Non cala il ferro mai che appiè n non colga:
N é coglie appien che piaga a ltru i non faccia; Nò piaga f a che l ’alm a altru i non tolga.
P re teriz io n e La
preterizione
(dapretereo,
io tralascio) o paralepsi (da ^-/paXci-to. tralascio) si ha q u a n d o si afferma di voler tacere u n a cosa che in tanto si dice. 11 Petrarca:Cesare taccio, che per ogni piaggia Fece l ’erbe sanguigne
Di lor vene, ove il nostro ferro mise.
IX.
Figure di pensiero C o m e si è detto, le figure di pen siero so n o quelle, per cui il pensiero stesso si atteggia in m o d o insolito. Esse si posso n o T su d d iv id ere in
figure d ’im
maginazione
e infig u re di affetto.
Figure d’im m aginazione Son quelle, in cui prevale l’im m agina zione eccitata. S ono le seguenti:
La similitudine
e la
comparazione, l ’antitesi, l ’ipotiposi, l ’etopeia,
laperso
nificazione
e laprosopopea,
lavisione,
ildialogismo.
Similitudine e co m p araz io n e La
similitudine è quella
—
—
—
—
figura, per cui la nostra im m agina zione nota le sim iglianze fra du e cose. Es:
Pauroso come un coniglio.
11 Carducci:E il dato de l ’aprile Move le biade in flore, Come un sospir d ’amore Di nova sposa il vel.
Le sim ilitudini so n o viziose, q u a n d o si derivano da so miglianze inesistenti o tr o p p o lontane, o si p a ra g o n an o cose note a ignote, o cose concrete ad astratte, o il para gone è tratto da cose triviali o sconvenienti. Sono quindi riprovevoli le sim ilitudin i se g u en ti:
Bella come il sorriso di D io
Le
nubi sembravano materasse aeree.
Se le somiglianze fra le d u e cose paragonate sono n o tate a parte a parte, la
similitudiue
piglia il n om e dicom
parazione (comparo,
io paragono). L’Ariosto:Come im pasto leone in stalla piana Che lunga fame abbia smacrato asciutto, Uccide, scanna, sbrana, a strazio mena L ’ infermo gregge in su a balia condutto; Cosi il crudel pagan nel sonno svena La nostra gente e fa macel per tutto.
Antitesi (Da avriTt'Or^t, io po n g o a fronte). L
'antitesi
è quella figura, che p a r a g o n a n d o fra loro d u e cose ne fa risaltare le differenze. 11 Manzoni:
T utto ei provò: la gloria Maggior dopo il periglio, La fuga e la vittoria, La reggia e il tristo esiglio, Due volte nella polvere. Due volte su gli aitar.
—
Ipotiposi (Dal greco O otd oV io rappresento). È la descrizione molto viva d ’una cosa, talché se m b ri vederla. È u n a bella
ipotiposi
questa descrizione, che ci fa il Man zoni, d ell’avvicinarsi rec iproc o di d u e s q u a d re nemiche :Quinci s p u n ta per l ’aria u n vessillo ; Quindi un altro s ’avanza spiegato ; Ecco appare un drappello schierato; Ecco un altro che incontro gli vien.
La
prosopografia
è u n a specie d ’ipotiposi
(da -pc'co-ov. aspetto, e y s c r i v o ) che ci dà una vivace ed esatta descrizione delle fattezze d ’ un u om o, o d ’ un animale (nel qual caso pu ò dirsiteriografia),
o d ’un essere im maginario. NellaGerusalemme Liberata :
P iù suso a lq u an to il passo lor contende Fero Leon, che rugge, e torvo guata, E i velli arrizza, e le caverne orrende De la bocca vorace apre, e dilata.
Etop^ia Anche questa figura è una specie d ’
ipotiposi
( d a loo;, costume, e ttocsm, io faccio ). F u detta dai latini
morum expressio.
E la viva descrizione dei costumi d ’ un in dividuo. Ecco, nel Tasso,Yetopeia di Argante:
L ’altro è il Circasso Argante, uom che straniero Sen venne alla Reai Corte d ’ Egitto,
Ma dei Satrapi fatto è dell’ Impero, E in som m i gradi alla milizia ascritto. Impaziente, mesorabil, fero,
Ne l ’arm e infaticabile ed invitto, D'ogni Dio sprezzatore, e che ripone Ne la spada sua legge e sua ragione.
— -
Personificazione È quella figura per la quale si attri buisce vita e m oto ad esseri inanimati, o morti, o a cose astratte. L’Ariosto :
In questo albergo il grave Sonno giace : L'O zio da u n canto corpulento e grasso: Da l ’altro la Pigrizia in terra siede,
Che non può andare, e mal reggesi in piede.
La
personificazione
chiamasi p r o p ria m e n teprosopopea,
(da pofjwTiov, volto, persona) q u a n d o all’essere personificato si attribuisce anche il discorso. Così, nel C arducci, parla 1’ Italia che va a visitare il m o d e rn o C a m p id o g lio :
Zitte ! zitte ! Che è questo frastuono Al lum e della l u n a ?
Oche del Campidoglio, zitte ! lo sono L ’ Italia grande e una.
Visione Si ha, q u a n d o l’ im m agina zione com m ossa ci fa quasi vedere e udire le cose passate, le fu tu re e le lontane. Nella
Canzone all'Italia,
del Leopardi :Attendi, Italia, attendi, lo veggio, o p an n i, Un fluttuar di tanti e di cavalli,
E fum o e polve e luccicar di spade Come tra nebbia lampi.
Dialogismo (Da StxXsyo), io discuto). Q uesta figura è detta an c h e
sermocinazione
(dasermocino/’,
io discorro) ed è un breve dialogo, vero o supposto, che s ’ in te rpone nel discorso. Q u e s t ’esempio è del Colletta: «Domenico Cirillo,
domandato dell’età, rispose :
«sessantanni » ; della condi
zione: » medico sotto il principato, rappresentante del popolo
—
-—
—
nella repubblica ». Del quale vanto sdegnato il giudice Spe
ciale, dileggiandolo disse:
«e che sei in mia presenza? »
— « In tua presenza
,codardo, sono un eroe ! » — Fu con
dannato a morire.
X.
Fig ure di a ffetto T ra le
figure di pensiero,
sono lefig ure di affetto
. S ono quelle particolari m aniere di parlare, che so n o più atte ad es p rim ere l’a n im o commosso. Una d o n n a del popolo (la quale non sa di rettorica) se piange il p r o p rio figlio morto, gli parla co m e se fosse vivo(apostrofe),
dà in
esclamazioni,
ininterrogazioni,
inpreghiere,
inimpre
cazioni,
ecc. Oltre a queste, userà, senza saperlo, figure d ’ im m aginazione, e figure di parole, e tutti i tropi più arditi; perc hè q u a n d o l’an im o è c om m osso, anche l’immaginazione e il pensiero sono più viv am ente agitati: agitazione che trova il suo sfogo naturale nel lin g u a g g io figurato. O n d e con molta verità osservòVito Fornari
(come innanzi si è notato), che il lin g u a g g io fig urato è m alam ente dettolinguaggio impro
prio ;
perchè esso è illinguaggio proprio
della passione e della fantasia.Le
figure d'affetto
prin cipali sono: L’interrogazione,
lasubiezione, Xesclamazione, Xepifotiema, Vapostrofe,
lapre
ghiera
e lapermissione,
laimprecazione,
ladubitazione,
lasospensione,
lacomunicazione.
I n te r ro g a z io n e L’
Interrogazione
( d e t t a dai Greciic
TTjax) è il presentare sotto fo rm a di d o m a n d a una cosa di cui siamo certi. P etrarca :Non è questa la patria in cui mi fid o ?
—
Q u esta d o m a n d a non è che una form a insolita, più a p passionata, dell'affermazione:
Questa è la patria in cui mi fid o.
Subiezione Si ha la
subiczione
(subiectio
, àv rontocpop*. il soggiungere) q u a n d o alla d o m a n d a si a g g iu n g e u n ’acuta risposta. Metastasio :Ma in che dobbiam fidarci? In quei teso ri? D ’ un istante son dono ;
Può involarli un istante. In questi amici Che acquistar già mi vedi ? E non son miei. Vengon con la fortuna, e van con lei.
Esclamazione Q uesta figura (in g reco ix^:óv /j<n;) con siste neH’esprim ere un q u a l u n q u e gagliardo affetto con u n ’in teriezione e u n' invocazione q u a lu n q u e . Nel Tasso :
O Cielo ! O Dei ! perchè soffrir q u est’empi ?
D ante :
Ahi ! dura terra, e perchè non t ’ap risti?
Epifonema
L'epifonema
( d a h ^ ( o v ; w , e s cla m o ) non è che u n ’ esclamazione, posta a conclusione d ’ un discorso. Ariosto :E così Orlando arrivò quivi appunto. Ma tosto si pentì d ‘esservi giunto, Cliè vi fu tolta la sua donna poi :
Ecco il g iu d izio u m a n come spesso erra !
A postrofe (D a à7ro<rrp£<j>M, volgo altrove). Q uesta fi g u r a ( detta dai latini
aversio
) si ha, q u a n d o il discorso si rivolge da quelli, a cui era indirizzato, ad altri, o ad assenti, 0 a morti, o ad esseri inanimati, o astratti. LTAlfieri ; — — — —
... O sacra
Tomba del re dei re, vittim a aspetti?
L ’a v r a i. E il Leopardi :
Oh venturose, oli care, oh benedette L ’antiche età, che a morte
Per la patria correan le genti a squadre ! E voi sempre onorate e gloriose,
O Tessaliche strette,
Dove la Persia e il fato assai meri forti F u r di poche alme franche e generose.
P re g h ie r a . È detta an c h e
deprecazione
(dadepreco/').
Consiste nell’ invocare soccorso dalla Divinità o da chi può recar conforto e aiuto. Nella
Gerusalemme,
ecco con quali parole A rm ida sc o n g iu ra G o ffred o :Per questi piedi, onde i superbi e gli empì Calchi; per questa m an che il dritto aita; Per l ’alte tue vittorie, e per quei tempi Sacri, cui desti, e cui dar cerchi aita, Il mio desir tu che puoi solo adempi....
La
preghiera
è spesso p r e c e d u ta d a\Yaugurio:
Dante:Se tosto grazia risolva le schiume Di vostra coscienza, sì che chiaro Per essa scenda della mente il lume, Ditemi (che mi sia grazioso e caro)
S ’a n im a è qui tra voi, che sia latina.
Dove si noti, che quel
se
del prin cipio è la particella au gurativa, non ipotetica (dasic,
non dasi).
Affine alla
deprecazione
è lapermissione,
che si ha q u a n d o per com m uovere, si offre altrui.d i far qualche cosa in nostro d an n o . Nella stessaGerusalemme
, il g u e rrie roTancredi
cerca con questa figura d ’ ispirare pietà e a m o re alla g u e r rie ra C lorinda :Ecco, io chino le braccia, e t ’appresento Senza difesa il p e tto : or che noi fìedi ? Vuoi che agevoli l ’o p ra ? Io son contento T rarm i 1’ usbergo or or, se n udo il chiedi.
I m p re c a z i o n e C ontra ria alla
preghiera
è l’imprecazione
(da
imprecor
), per la quale si a u g u r a ad altri o a noi stessi tutto il male desiderato. Nell'Eneide
di Virgilio, tradotta da Annibai Caro, così parla la regin a D id o n e :E la terra m ’ingoi, e il ciel m i fu lm in i E n e ll’abisso m i trabocchi in prim a C h’io ti violi m ai, pudico am ore.
Dubitazione (In greco 3'.a7rcpy|cjt<;). È l’espressione di u n ’agitazione violenta, che ci fa perplessi e incerti di ciò che d o b b ia m o dire o fare. Olim pia, a b b a n d o n a ta da Bireno, così si lamenta
ne\YOrlando furioso:
T ornerò in F ia n d ra, ove ho venduto il resto Di che io vivea, benché no n fosse m olto, Per so v v en irti e di prigione trarte ? M isera! dove a n d rò ? Non so in qual parte. Debbo forse ire in F risa , ove io potei,
E per te non vi volsi, esser re in a ? ....
Sospensione Q uesta figura, detta p u re
sostentazione
, si ha q u an d o , com m ossi d a un a cosa terribile o a t r o c e , o—
—
po rten to sa, m ostria m o r ip u g n a n z a ad esporla, e teniamo per un pezzo sospesi gli anim i degli uditori. 11
Monti
nellaBasvilliana:
Perocché dai costoro em pio fu ro re
A g itta r trascin ato
(ahi! parlo o taccio?)
Dei ribaldi il capestro al m io Signore, Di m an m i cadde l ’esecrato laccio.
Comunicazione (’Avxxoi'vojffi?). U siam o q uesta figura q u a n d o , tr o p p o convinti della ragio nevolezza d ’ima cosa, d o m a n d ia m o il consiglio e il pare re di quelli s t e s s i , a cui o co n tro cui parliam o. C icerone, in u n ’ orazio ne contro Verre: « O r a d o m a n d o a v o i , che cosa crediate che io d e b b a fare
».
Correzio ne (’K xTo'pGwctc). E quella figura per cui, a p p e n a detta u n a cosa, ac corgendoc i di aver detto poco o male, a g g iu n g ia m o anc ora qualche cosa. 11
Petrarca,
nellaCanzone alta Vergine:
V ergine saggia, e del bel n u m e r u n a Delle beate vergini p ru d en ti,
A n zi la p rim a e con p iù chiara lampa.
O r a che a b b ia m o fatta u n a e n u m e r a z i o n e , abbastanza completa, dei tropi e delle figure, co n c h iu d ia m o , col dare qualche avvertenza in to rn o all’uso del linguaggio figurato:
1.° Le figure allora so n o belle, q u a n d o nascono, opportune e sp onta nee, dal soggetto che si tratta; 2.° Le figure stirac chiate e strane, o faticosamente com binate, non sono mai belle; le figure d e b b o n o nascere daH 'im m agin azio ne e dalla passione, n o n da un freddo sforzo d ell’intelligenza; 3.° Le fig ure riescono noiose e stucchevoN , q u a n d o son troppo
—
—
—
co n tin u e o frequenti; c’è, negli scrittori, brani bellissimi, o sublimi, spogli al tutto di figure e di traslati; 4.° B isogne rà anche badare che i tropi e le figure non siano contra dittori tra loro, o nelle loro parti: com e, per esem pio , se Dante, nell’allegoria più innanzi citata, avesse scritto
P er un campo ìnigliore
alza le vele Ornai la navicella del mio ingegno;sarebbe assai curio so l ' im m aginare un a navicella, che alza le vele per un
campo
, invece cheper miglior acqua!
XI.
Invenzione F in o ra si è parlato dell’
elocuzione.
Ma se la letteratura stu dia (come si è detto)la conveniente e-
spressione del pensiero
, è chiaro che la ricerca e la d isp o sizione dei pensieri, acconci al tem a che svolgesi , è u n a parte im porta nte della letteratura. Il trovare i pensieri per lo svolg im ento del tema, è ciò che a p p u n t o chiamasiinven
zione.
V eram ente, per trovare i pensieri convenienti a un sog getto, non vi può essere che una sola n o rm a f o n d a m e n ta le:
sentire
emeditare.
Gli antichi rétori però classificarono d iligente m e nte le fonti, a cui si possono attingere le idee, e le c h ia m a ro n oluoghi comuni
otopici
(da totto; luogo). Ec cone alcuni:La definizione Consiste nel dar b rev e m en te u n a chiara ed esatta idea della cosa di cui si ragiona. O gni trattato scientifico deve partire dalla definizione. L’ usarla però nella prosa co m u n e e amena, riesce pedantesco e pesante,
-— —
e sarà meglio sostituirvi la
descrizione
(di cui si parlerà nella 2.a parte).Il gen e re e la specie P er allargare il ca m p o delle idee, si p u ò parlare del
genere
ospecie,
a cui appartiene la cosa, di cui trattiam o. Così, p a rla n d odt\Yavarizia,
si può parlare del vizio in generale. È u nluogo comune,
a cui ri c o rr o n o tro p p o spesso i giovani, q u a n d o so n o a corto d’idee. Le cause e gli effetti Ripetiam o l’esempio: dovendo scrivere d ell’avarizia,
si p u ò d isc o rre re delle cause che lapr o d u c o n o , e dei tristi effetti che ne derivano.
I contra rii A ncora lo stesso esempio: p e r far meglio notare la b ruttezza
avarizia,
le si pu ò mettere a fronte la bellezza dellagenerosità,
cioè delsuo contrario.
Le somiglianze e le aff in ità P e r allungare un p o ’ la co m posizio ne, si po sso n o pigliare concetti da argomenti affini. I giovani c o n o s c o n o p e r prova q uesto
luogo comune
che spesso li se duce al pu n to , da non far loro imbroccare il vero tema.
Gli esempi Q uesti si po sso n o trarre benissim o dalla storia, o dalla p r o p ria esperienza. L’inventarli, che siano ben calzanti, è m olto più diffìcile.
L’e num eraz ione Consiste nel distin g u e re una cosa nelle sue varie parti.
1
luoghi comuni
p o ssono essere di qualche giovamento ai giovanetti, scarsi o tardi d ’idee, i quali fanno le prime prove del c o m p o rre . S o n o però com e i sugheri, che bis ogna lasciar via, a p p e n a ci se ntia m o atti, non dico a nuota re, ma a te nerci tanto q u a n to a galla.-— — — —
XII.
Avvertenze Q u a n t o alla ricerca dei pensieri, e alla loro disposizione nello scrivere, si tengano se m p re in mente dai giovani le seguenti avvertenze:
1.a È utile abituarsi a osservare attentam ente e a no, tare nella m e m o ria ogni cosa: i fatti che ci accadono tutti i gio rni, i moti b uoni o tristi d e j J J ^ r ^ ^ 'n t ì ^ t r o , le gioie e i dolori nostri e dei nostri s i m i ^ ^ f t ' ^ a s p e ^ /0 ^ u o g h i , i co stum i delle varie età e delle va/re condizioni ohgTi\ o m i n i ecc. N o n vi è circostanza così n f i^ ita , che, ben*M s€nrata e ben espressa, non possa poi o p p ^ u n a i ^ t t t e
'jà&tvifcfc
in un rac conto, in una descrizione, in\\
n a \ d issa A z i o n e / ^ a s s e r v a r e è u n a delle prim e qualità n e c e ^ a v ^ s j j j o sfflf l o ^ / Ed è una qualità, che molto si rafforza con. t’a f c f ìt f; ^ € ie nei giovani. I quali faranno bene ad assuefarsi a g u a r d a r bene in to rn o a sè, e a scrivere di ciò che sa n n o e vedono e o d o n o e spe rim e n tan o quotidiana m ente, invece di parla r di cose e luoghi ignoti e lontani dalla loro esperienza. T e n g a n o sem pre bene a mente, che anche chi scrive male, q u a n d o discorre di cosa vista o provata, scrive p u r se m p re meglio.2.a E utile il leggere b u o n i scrittori, e m a n d a r n e a m e m oria pensieri, sentenze, brani interi di versi o prosa, e av vezzarsi a servirsene, citandoli a proposito nei proprii scritti. È anche utile trascrivere in uno speciale q u a d e r n o note voli passi di scrittori.
3.a P rim a di mettersi a scrivere, biso g n e rà sa m p re aver ben m editato il p r o p rio soggetto, e so p rattu tto aver pensato a ben c o m p re n d e r n e la natura e i confini. E un erro re in cui cad o n o qualche volta anche i giovanetti svegliati, quello di no n afferrare il vero tema, o di rasentarlo senza mai adde n
— _ - -
-trarvisi. Sarà bene anzi evitare i lunghi e lo ntani proemiij, pei quali poi si arriv a stanchi al vero n òcc iolo della que^ stione. Meglio en trare subito in materia. Trovati i pensierii, sarà bene il disporli con semplicità e o rd in e , non dimentii- c a n d o mai la verità o alm en o la verosimiglianza.
XIII.
Poesia Bisogna distinguere l’elo cu z io n e della prosa da quella della poesia. 1 tropi e le figure, di cui a b b ia m o parlato, si a d o p e ra n o anche in prosa, m a sono essenzial m ente pro p rii della poesia.
11 lingua ggio poetico è molto differente dal linguaggio della prosa. La prosa si rivolge principalm ente alla ragione; la poesia parla prin cip alm e n te al cu o r e e alla fantasia, e q u in d i am a i tropi e le figure (che, co m e si è detto, s o n o la espressione p r o p ria dell’an im o e d ell’ immaginazione co m mossi), i costrutti inversi, parole e frasi rare e disusate, certi latinismi e grecismi, e in gene rale tutte le f o rm e inso solite, e atte perciò ad esprim ere l’ insolito stato della mente e dell'anim o. La prosa è come l’ab ito di tutti i g io rn i, la poesia è il vestito di festa.
La poesia (ttouw faccio, creo) è quel linguaggio, che nasce dalla fantasia e dall’affetto com mossi.
Q u in d i il verso non costituisce da solo poesia; vi può essere poesia anche senza verso, e verso senza p o es ia.
U n verso, che non nasce dalla fantasia commossa, e che n o n ci co m m u o v e, non è poesia, anche quando è s o n o r o ed elegante. L’ad d io di Lucia a ’ su oi monti, nei
Promessi Sposi,
è poesia, b en c h é scritto in prosa. P erò è tale la forz a del sentim ento, che q u a n d o esso investe la prosa, la re n d e n a
-—
turalm ente p iù musicale, e m olto l’avvicina all’arm o n ia del verso. Si noti infatti, nell’
Addio
suddetto, com e fin dal principio vi sia quasi tutta u n a sequela di versi di varia m is u ra :Addio m onti, sorgenti d a ll’acque Ed elevati al cielo;
Cime in u g u a li, note a chi è cresciuto F ra voi e im presse ne la su a mente; Non m eno che lo sia
L ’aspetto de’ suoi p iù fa m ilia ri.
Il verso d u n q u e non costituisce l’essenza vera della poesia, ma esso ne è la c o m p iu ta e p r o p ria espressione.
Verso (da
verto)
vuol dire ritorno; rito rn o dello stesso accento, dello stesso n u m e ro di sillabe, dello stesso su o n o(rima)
in fine o in mezzo al verso.Ritmo Il carattere di tutti i versi, antichi e moderni, è il
ritmo.
11 ritm o è il vario avvicendarsi delle sillabe ac centate con le àtone (senz’accento).II verso greco e latino si fondava sul n u m e ro dei piedi (gruppi di d u e o più sillabe) e sulla lu nghe zz a o brevità delle sillabe, cioè sulla
quantità.
Il verso italiano si fonda sul n u m e ro delle sillabe, su ll’accento, sul ritmo.L’accento del verso è detto
accento ritmico,
il quale di regola coincid e con l’accento tonico
della parola. Si esercitino i giovani a d istin g u ere l’accento tonico di ciascuna parola, com e p. e.Amàre, fiévole, ammirévole, mormorano, carità,
dolòr
ecc Così facilmente e d u c h e r a n n o l’orecchio a sentire il ritm o e il m e tro del verso.M etro La varia m is ura dei versi dicesi
metro
( da uETfo;, m is u ra ); emetrica
si d i c e l ascienza dei varii metri.
—
—